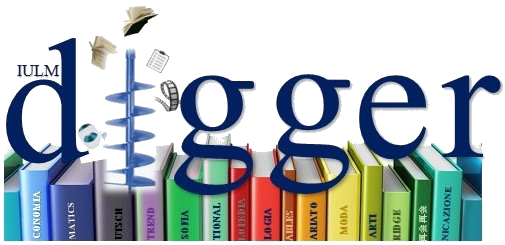Secondo una diffusa tradizione, alla donna è stato assegnato un ruolo subordinato rispetto all’uomo e le è stato intimato di fare un uso parco delle parole. “Delle donne che parlano molto non si può far buon giudizio” sentenziava lo scrittore del Cinquecento Giuseppe Passi, autore de I donneschi difetti. E agli inizi del Novecento, un personaggio del romanzo La crociera di Virginia Woolf ragguaglia il lettore sull’asimmetrico rapporto uomo-donna: “Fino a qualche anno fa le donne non erano mai uscite da sole e non parlavano mai. Per migliaia di anni questa curiosa vita di silenzio si è svolta sullo sfondo, senza che la vedessimo mai rappresentata. È ovvio che noi uomini scriviamo sempre di donne: per insultarle, per deriderle, o per adorarle; ma mai che siano le donne stesse a scrivere.” Per sottrarsi al gravoso, iniquo ruolo impostole dalla società, la donna si impegna da secoli. È riuscita non solo a uscire dalle mura domestiche, ma ha viaggiato nel mondo, anche in solitaria e spesso distinguendosi come esploratrice o travel writer. Di recente, contro il silenziamento, la donna ha messo in atto l’espediente del turpiloquio, generalmente considerato prerogativa maschile, che secondo l’opinione di Romolo G. Capuano è finalizzato “a costruire un nuovo ordine più equo e democratico, seppure attraverso veicoli espressivi - le ’parolacce’ e le bestemmie – approssimativi e disarticolati”. Nel presente lavoro vengono posti in evidenza gli aspetti negativi delle espressioni sconce e offensive, ma anche la funzione positiva del turpiloquio che aiuta a sopportare i disagi psicologici e le sofferenze fisiche, esprime ribellione contro l’autorità, manifesta un anelito al cambiamento.
L'uso sovversivo del linguaggio triviale femminile. Una tappa nel percorso verso la parità di genere, 2024-10.
L'uso sovversivo del linguaggio triviale femminile. Una tappa nel percorso verso la parità di genere
Neiger Giovanna
2024-10-01
Abstract
Secondo una diffusa tradizione, alla donna è stato assegnato un ruolo subordinato rispetto all’uomo e le è stato intimato di fare un uso parco delle parole. “Delle donne che parlano molto non si può far buon giudizio” sentenziava lo scrittore del Cinquecento Giuseppe Passi, autore de I donneschi difetti. E agli inizi del Novecento, un personaggio del romanzo La crociera di Virginia Woolf ragguaglia il lettore sull’asimmetrico rapporto uomo-donna: “Fino a qualche anno fa le donne non erano mai uscite da sole e non parlavano mai. Per migliaia di anni questa curiosa vita di silenzio si è svolta sullo sfondo, senza che la vedessimo mai rappresentata. È ovvio che noi uomini scriviamo sempre di donne: per insultarle, per deriderle, o per adorarle; ma mai che siano le donne stesse a scrivere.” Per sottrarsi al gravoso, iniquo ruolo impostole dalla società, la donna si impegna da secoli. È riuscita non solo a uscire dalle mura domestiche, ma ha viaggiato nel mondo, anche in solitaria e spesso distinguendosi come esploratrice o travel writer. Di recente, contro il silenziamento, la donna ha messo in atto l’espediente del turpiloquio, generalmente considerato prerogativa maschile, che secondo l’opinione di Romolo G. Capuano è finalizzato “a costruire un nuovo ordine più equo e democratico, seppure attraverso veicoli espressivi - le ’parolacce’ e le bestemmie – approssimativi e disarticolati”. Nel presente lavoro vengono posti in evidenza gli aspetti negativi delle espressioni sconce e offensive, ma anche la funzione positiva del turpiloquio che aiuta a sopportare i disagi psicologici e le sofferenze fisiche, esprime ribellione contro l’autorità, manifesta un anelito al cambiamento.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
GenderCultures_Proceedings_IULM_Italy_Published.pdf
Open Access
Dimensione
9.52 MB
Formato
Adobe PDF
|
9.52 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.