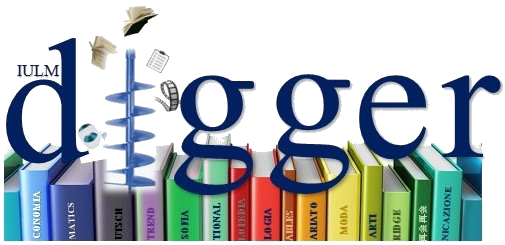Nell’intento di contribuire alla riflessione sulla sociologia della critica di Boltanski, l’articolo si concentra su alcuni elementi di difficoltà che vi appaiono non pienamente risolti e su interrogativi che sembrano ancora attendere risposte. Dopo aver ricostruito quale sia il posizionamento reciproco delle due parti che per Boltanski concorrono alla critica (soggetto competente e sociologo critico), sono quindi affrontate due questioni evidentemente connesse: l’individuazione dell’oggetto (cosa si critica?) e le condizioni intese come presupposti (cosa rende possibile la critica?). E da ciò emerge come un pensiero critico che si vuole fondativo e globale, come è quello di Boltanski, fatichi a dar conto di caratteristiche centrali come il genere e l’ascrivibilità di tipo etnico o “razziale”. Successivamente, l’attenzione si sposta sul bilancio tracciato da Boltanski dell’odierna stagione della critica, evidenziando così come vi restino messi solo parzialmente a fuoco aspetti come le condizioni realistiche per un rilancio della critica stessa e la saldatura di questa con esperienze concretamente emergenti. Se è infatti condivisibile l’enfasi boltanskiana sulla non autosufficienza del discorso specialistico per il cambiamento, resta ineludibile la tensione tra una scientificità comunemente intesa come sinonimo di astrazione e la fruibilità che dovrebbe invece accompagnare i soggetti nella mobilitazione e resistenza
Per una critica della sociologia della critica. Riflessioni sul contributo e l’opera di Luc Boltanski, 2019.
Per una critica della sociologia della critica. Riflessioni sul contributo e l’opera di Luc Boltanski
Emanuela Susca
2019-01-01
Abstract
Nell’intento di contribuire alla riflessione sulla sociologia della critica di Boltanski, l’articolo si concentra su alcuni elementi di difficoltà che vi appaiono non pienamente risolti e su interrogativi che sembrano ancora attendere risposte. Dopo aver ricostruito quale sia il posizionamento reciproco delle due parti che per Boltanski concorrono alla critica (soggetto competente e sociologo critico), sono quindi affrontate due questioni evidentemente connesse: l’individuazione dell’oggetto (cosa si critica?) e le condizioni intese come presupposti (cosa rende possibile la critica?). E da ciò emerge come un pensiero critico che si vuole fondativo e globale, come è quello di Boltanski, fatichi a dar conto di caratteristiche centrali come il genere e l’ascrivibilità di tipo etnico o “razziale”. Successivamente, l’attenzione si sposta sul bilancio tracciato da Boltanski dell’odierna stagione della critica, evidenziando così come vi restino messi solo parzialmente a fuoco aspetti come le condizioni realistiche per un rilancio della critica stessa e la saldatura di questa con esperienze concretamente emergenti. Se è infatti condivisibile l’enfasi boltanskiana sulla non autosufficienza del discorso specialistico per il cambiamento, resta ineludibile la tensione tra una scientificità comunemente intesa come sinonimo di astrazione e la fruibilità che dovrebbe invece accompagnare i soggetti nella mobilitazione e resistenza| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Boltanski per QTS.pdf
Accessibile solo dagli utenti con account Apeiron
Descrizione: Testo articolo
Tipologia:
Documento in Post-print
Dimensione
116.3 kB
Formato
Adobe PDF
|
116.3 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.