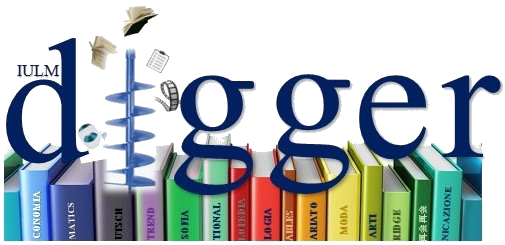La musica delle sirene e la natura ambigua del loro canto vengono definiti da Horkheimer e Adorno la “voce dell’irrevocabile”. Voce che, con la contemporaneità, tende ad annullarsi, trasformandosi in singhiozzo sincopato che gronda parole di perdita al limite del silenzio. Emerge in filigrana una filosofia della voce e del silenzio che si articola su due poli: quello dei “suoni-evento” (il canto malioso delle sirene e le sue conseguenze) e quello dell’“analitica dell’ascolto” (quello dei naviganti, l’astuto non-ascolto di Ulisse, quello dei lettori e più in generale l’ascolto come evento-relazione tra suono e ascoltante). Le sirene mute sintetizzano allora la condizione del soggetto contemporaneo, auto-produttore di voci e suoni e dimentico del suo ascolto mortale, incapace quindi di cogliere l’ineffabilità del loro silenzio. Nei secoli XIX, XX, XXI molti autori, italiani e no, dedicano numerose pagine alle sirene: vi è chi resta nel solco della tradizione senza discostarsi sostanzialmente dalla rappresentazione che ce ne davano gli antichi; c’è chi rovescia il topos, che da bello e fantastico si trasforma in brutto e reale; c’è chi, infine, lo annulla. Il percorso proposto si interroga sui diversi modi in cui il mito antico viene analizzato e rinnovato, per mettere in luce le diverse proiezioni che costruiscono e ricostruiscono tale mito. Così facendo, illustra come sia cambiato il modo della sirena di presentarsi, di muoversi, di avvicinarsi e di entrare in relazione con l’uomo, modo che mostra come si è passati dal dover difendersi dalle sirene al doverle difendere. Al centro del discorso non c’è solo il soggetto che provoca l’incantamento − le sirene − ma anche l’oggetto dell’incantamento − l’uomo − e tale discorso è propedeutico al passaggio dall’incanto al disincanto. La lunga parabola si snoda dalla tradizione del mito alla sua pseudo-cancellazione attraverso le molteplici immagini letterarie che dal modello primario, punto di partenza sempre tenuto presente come pietra di paragone, si trasformano in fenomeno socio-economico (pubblicità, cinema, fumetti, canzoni). Senza creare una faglia col passato, l’antico mito è tenuto in vita attraverso la ricerca di nuovi modelli, modernizzando e modificando l’antico.
La sirena in figura: forme del mito tra arte, filosofia e letteratura, 2017-11.
La sirena in figura: forme del mito tra arte, filosofia e letteratura
Moretti, Simona;Boccali, Renato;Zangrandi, Silvia
2017-11-01
Abstract
La musica delle sirene e la natura ambigua del loro canto vengono definiti da Horkheimer e Adorno la “voce dell’irrevocabile”. Voce che, con la contemporaneità, tende ad annullarsi, trasformandosi in singhiozzo sincopato che gronda parole di perdita al limite del silenzio. Emerge in filigrana una filosofia della voce e del silenzio che si articola su due poli: quello dei “suoni-evento” (il canto malioso delle sirene e le sue conseguenze) e quello dell’“analitica dell’ascolto” (quello dei naviganti, l’astuto non-ascolto di Ulisse, quello dei lettori e più in generale l’ascolto come evento-relazione tra suono e ascoltante). Le sirene mute sintetizzano allora la condizione del soggetto contemporaneo, auto-produttore di voci e suoni e dimentico del suo ascolto mortale, incapace quindi di cogliere l’ineffabilità del loro silenzio. Nei secoli XIX, XX, XXI molti autori, italiani e no, dedicano numerose pagine alle sirene: vi è chi resta nel solco della tradizione senza discostarsi sostanzialmente dalla rappresentazione che ce ne davano gli antichi; c’è chi rovescia il topos, che da bello e fantastico si trasforma in brutto e reale; c’è chi, infine, lo annulla. Il percorso proposto si interroga sui diversi modi in cui il mito antico viene analizzato e rinnovato, per mettere in luce le diverse proiezioni che costruiscono e ricostruiscono tale mito. Così facendo, illustra come sia cambiato il modo della sirena di presentarsi, di muoversi, di avvicinarsi e di entrare in relazione con l’uomo, modo che mostra come si è passati dal dover difendersi dalle sirene al doverle difendere. Al centro del discorso non c’è solo il soggetto che provoca l’incantamento − le sirene − ma anche l’oggetto dell’incantamento − l’uomo − e tale discorso è propedeutico al passaggio dall’incanto al disincanto. La lunga parabola si snoda dalla tradizione del mito alla sua pseudo-cancellazione attraverso le molteplici immagini letterarie che dal modello primario, punto di partenza sempre tenuto presente come pietra di paragone, si trasformano in fenomeno socio-economico (pubblicità, cinema, fumetti, canzoni). Senza creare una faglia col passato, l’antico mito è tenuto in vita attraverso la ricerca di nuovi modelli, modernizzando e modificando l’antico.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
La sirena in figura.pdf
Open Access dal 03/12/2020
Descrizione: Intero volume
Dimensione
1.01 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.01 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.