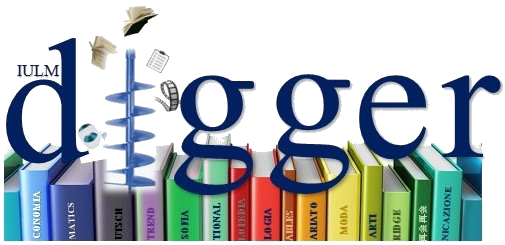Il capitolo svolge una serie di brevi riflessioni concatenate concernenti le difficoltà, artistiche e inscindibilmente sociali, della composizione e del mestiere della composizione oggi in Italia. La prospettiva assunta è critica in senso etimologico: mira a individuare i punti di equilibrio precario, potenzialmente distruttivo oppure produttivo, dove tra le spinte e le controspinte che la dilaniano la musica accademica contemporanea può cadere oppure risollevarsi. Anzitutto è considerata la condizione dei compositori nel campo economico e comunicazionale: scissi tra professionismo e non professionismo, tra attività creativa e autopromozione, tra canali di diffusione vecchi e nuovi, tra operatività nazionale e internazionale, essi creano il loro stesso mestiere. Successivamente sono osservate le forze che in maniera contrastante agiscono sulla composizione nel campo culturale: la molteplice dialettica istituzionalizzazione vs marginalità, acculturazione vs ghettizzazione culturale, culturalismo vs cultura vs artigianalismo, nonché il rapporto con la tecnologia. Dopodiché le implicazioni rispetto al potere, al “sistema”: i compositori sono dibattuti tra antagonismo e conformismo, tra sperimentazione e stereotipizzazione, tra purismo e trasversalità stilistica (vale a dire sociale). A seguire la composizione è inquadrata fra le diverse pratiche artistiche ed estetiche: i compositori sono creatori di musica pura ma più volentieri di musica commista ad altre arti; e a loro modo sono anche interpreti e ascoltatori. Poi la composizione è esaminata in quanto pratica speciale fra le diverse pratiche umane: come mezzo per la costruzione di un'identità più o meno marcatamente personale, corporea, di genere, di orientamento erotico, e perfino come strumento per l'eccesso (analogamente a droga, sesso ecc.). Infine sono studiati i casi singolari di due compositori italiani viventi, Gilberto Cappelli (1952-) e Dario Buccino (1968-): anomali per diverse ragioni rispetto agli standard del mestiere descritti, perciò marginali nel circuito della musica contemporanea, ma forse centrali secondo una prospettiva storico-stilistica che prescinda dai diktat della ristretta attualità.
Il mestiere del compositore oggi: spinte e controspinte, 2017.
Il mestiere del compositore oggi: spinte e controspinte
Lombardi Vallauri, Stefano
2017-01-01
Abstract
Il capitolo svolge una serie di brevi riflessioni concatenate concernenti le difficoltà, artistiche e inscindibilmente sociali, della composizione e del mestiere della composizione oggi in Italia. La prospettiva assunta è critica in senso etimologico: mira a individuare i punti di equilibrio precario, potenzialmente distruttivo oppure produttivo, dove tra le spinte e le controspinte che la dilaniano la musica accademica contemporanea può cadere oppure risollevarsi. Anzitutto è considerata la condizione dei compositori nel campo economico e comunicazionale: scissi tra professionismo e non professionismo, tra attività creativa e autopromozione, tra canali di diffusione vecchi e nuovi, tra operatività nazionale e internazionale, essi creano il loro stesso mestiere. Successivamente sono osservate le forze che in maniera contrastante agiscono sulla composizione nel campo culturale: la molteplice dialettica istituzionalizzazione vs marginalità, acculturazione vs ghettizzazione culturale, culturalismo vs cultura vs artigianalismo, nonché il rapporto con la tecnologia. Dopodiché le implicazioni rispetto al potere, al “sistema”: i compositori sono dibattuti tra antagonismo e conformismo, tra sperimentazione e stereotipizzazione, tra purismo e trasversalità stilistica (vale a dire sociale). A seguire la composizione è inquadrata fra le diverse pratiche artistiche ed estetiche: i compositori sono creatori di musica pura ma più volentieri di musica commista ad altre arti; e a loro modo sono anche interpreti e ascoltatori. Poi la composizione è esaminata in quanto pratica speciale fra le diverse pratiche umane: come mezzo per la costruzione di un'identità più o meno marcatamente personale, corporea, di genere, di orientamento erotico, e perfino come strumento per l'eccesso (analogamente a droga, sesso ecc.). Infine sono studiati i casi singolari di due compositori italiani viventi, Gilberto Cappelli (1952-) e Dario Buccino (1968-): anomali per diverse ragioni rispetto agli standard del mestiere descritti, perciò marginali nel circuito della musica contemporanea, ma forse centrali secondo una prospettiva storico-stilistica che prescinda dai diktat della ristretta attualità.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
mestiere scansione.pdf
Non accessibile
Dimensione
1.57 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.57 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.